Recensione "Cosmo" di Witold Gombrowicz

"Mi rallegra il niente, perché niente è, né più né meno, quello che una fa per tutta la vita"
Cosmo è un romanzo strabiliantemente doloroso e allo stesso tempo poetico. Di che parla? Parla di niente, perché niente è quel che facciamo per tutta la vita, per dirla come direbbe Gombrowicz. Il protagonista è un ragazzo che, per combattere la solitudine, va a trascorrere un periodo lontano da casa con un suo amico. Qui una serie di coincidenze sinistre stimoleranno la loro suggestionabile mente fino a portarli a cercare una corrispondenza tra i segnali scovati; nella prima metà del romanzo, osserviamo i due ragazzi muoversi come detective tra le loro stesse suggestioni, nel tentativo monco di dare ordine al caos, un caos che tra le pagine emerge con naturale prepotenza e che, nella seconda parte del romanzo, arriva a sovrastare l'intera impalcatura dello stesso e a sovvertire le regole narrative. Non aggiungo altro, lascio alla lettura e al vostro godimento mentale l'amara ebrezza di addentrarvi nelle pieghe di questo libro splendidamente doloroso, perché Cosmo un libro che va scoperto, va sorseggiato; è una passata di sale sulla grande ferita umana, quella che deriva dal nostro eterno chiederci il significato dall'esistenza. La risposta la conosciamo, eccome se la conosciamo, la vogliamo ignorare, e Gombrowicz ce la vuole fare ingerire a forza.
Prima di concludere, nota di merito per Il Saggiatore: la veste editoriale, la cura grafica e la traduzione restituiscono l'originaria intensità dello scritto con fedeltà encomiabile. Ninete è fuori posto: la copertina veicola perfettamente il senso del romanzo, la traduzione è eccelsa, e la postfazione ( sì, finalmente una postfazione) è una chicca prelibatissima. 22 euro ma ben spesi.
Recensione ( fumantina) "Puzzle" di Franck Thilliez
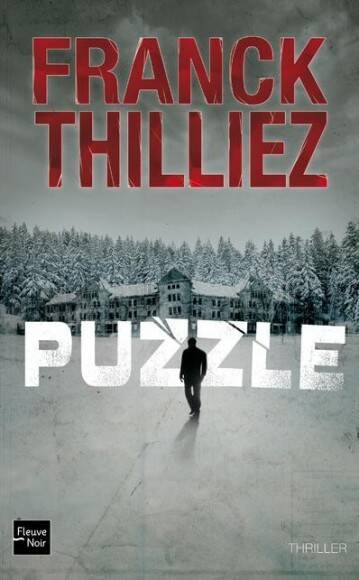
Arriva un momento, nella vita degli autori di Thriller, in cui la vena creativa viene subordinata al denaro. Il primo che mi viene in mente è Carrisi. Quattro, cinque titoli centrati bene, per poi iniziare a vendere carta scritta. Mi direte che questo avviene per tutti. Forse. Quello che è certo è che per Thilliez è senz'altro così. Puzzle è una disgustosa paraculata scritta per contratto più che per esigenze narrative. L'unico scopo era vendere, e per farlo è stato proposto con una presentazione appetitosa che avrebbe fatto gola persino ai meno avvezzi al genere. E infatti, stando alla sinossi, uno penserebbe di stringere tra le mani il thriller dell'anno, partorito da una mente suprema; in realtà, di suprema, c'è stata solo la noia che più e più volte mi ha quasi portato a defenestrare il libro dal treno in corsa. Puzzle è un guazzabuglio di fregature, informazioni trascurabili e fumo negli occhi. Non ho mai letto nella mia vita un thriller così lento e ricco di dettagli inutili; in confronto Faletti era un maestro della suspence. E Dio - e chiunque abbia idea di come si scriva un giallo - lo sa che non lo era. Il finale si conclude con un espediente che è un putrido riciclaggio di copioni antichissimi, scontato come la neve sulla cima dell'Everest ad Agosto. Quasi offensivo per quanto abusato. Nientemeno che la classica trovata di uno scrittore poco audace costretto da obblighi editoriali, che deve mettere il punto al manoscritto e consegnarlo entro i tempi prestabiliti. Non mi capacito di come sia possibile che la Fazi, quella che pubblica Wilkie Collins, abbia trovato l'ardore di mandare alle stampe questo aborto mentale su carta. Non voglio più sentire parlare di questo libro, dell'autore, di niente che lo riguardi.
Recensione "Abbiamo sempre vissuto nel Castello" di Shirley Jackson

A volte l'approccio può cambiare le sorti di una lettura. Conoscevo Shirley Jackson, ero già stato battezzato dai sottili orrori della mente che serpeggiano nell'incubo di Hill House; avevo già fatto i conti con l'ambiguità, con la stratificazione di significati che permea la sua prosa, e con lo straniamento che si annida tra le righe della narrazione. Sapevo cosa aspettarmi, sapevo quali lenti indossare affinché il contenuto non mi risultasse assurdo, o piatto, peggio ancora, inconsistente, e diminuisse la possibilità di perdersi tra le analogie della sua scrittura.
Siamo di nuovo in un luogo chiuso, in una casa, come nell'altro già citato romanzo, uno spazio che segna la costante simbolica di tutto il romanzo: il conflitto tra il fuori e il dentro, il pericolo e la sicurezza, la norma sociale e lo straniamento. Il romanzo mette in scena la vita apparentemente semplice e normale di due sorelle, di cui una, la minore, è narratrice e protagonista ( prototipo perfetto di narratore inaffidabile). Le due si ritrovano a vivere nel castello di famiglia insieme allo zio in seguito a una tragedia che ha sterminato la maggior parte dei componenti della loro famiglia. La loro abitazione è una bolla, che le tiene isolate in una realtà alternativa creata dalle loro mani. La storia scorre senza grandi turbolenze fino a un evento che funge da spartiacque nel romanzo e che rivela tutta l'assurdità celata tra le pagine.
L'orrore di Shirley Jackson è un orrore privo di eccessi o grandi stridori, di sangue non ce n'è neanche una traccia, mostri men che mai. Ma l'orrido c'è, è presente, si insinua nelle crepe e serpeggia silenzioso, sussurra, si scorge, si avverte, è il sottofondo costante di tutto la storia; c'è un qualcosa - non si sa bene dire cosa - nel corso della lettura, che disturba, inquieta, tiene alta l'attenzione; alla bambina protagonista sono messe in bocca parole grottesche, che se all'inizio fanno abbozzare un sorriso, dopo diventano raccapriccianti, e addensano l'atmosfera; lo zio - simpaticissimo - è affetto da demenza senile, fa piegare le labbra, ma è un altro di quegli elementi che contribuisce ad aumentare il senso di ambiguità; ad addensare l'atmosfera sinistra, c'è un corredo di riti che si ripetono sempre uguali lungo tutto il romanzo; si tratta certo di riti famigliari, concernono il cibo, la colazione, il pranzo, il tè, ma si percepisce sempre qualcosa di sottilmente agghiacciante, qualcosa a cui non si riesce mai a dare un nome. E poi, fuori dal castello, fuori dalle mura di questa nuova realtà, le voci impietose della massa, l'etica ipocrita del popolino che, senza pietà, senza empatia, fa cadere la gogna del giudizio sulle due sventurate sorelle.
Attenti quando vi avvicinate a questa scrittrice, ridimensionate le aspettative, non perché la qualità sia di valore inferiore rispetto a quanto si dice, anzi, il contrario: perché le letture sono molteplici e si rischia di inciampare nella patina apparente di normalità e nelle aspettative di un pubblico che cerca il brivido; l'orrore qui non urla, non fa accapponare la pelle, non è il salto dalla sedia, questi romanzi rappresentano piuttosto lo scricchiolio del vecchio mobile di casa, sono la crepa del muro della propria abitazione, che giorno dopo giorno, anno dopo anno apre le porte al terrore, e segna l'incepparsi impercettibile della mente, la rotella che spezza l'ingranaggio, il ghigno oscuro dietro le tende di casa. Cautela, estrema cautela, quando ci si avvicina a Shirley Jackson: sapeva bene cosa scrivere e come scriverlo, e conosceva bene gli anfratti oscuri della mente, l'orrore della normalità. Abbiate cautela e vi assicuro, vi godrete una lettura piacevolissima capace di farvi discutere per molti molti giorni.
Recensione "L'eredità di Eszter" di Sandor Màrai

"Rivedere una persona che abbiamo amato è forse un po' come tornare sul luogo del delitto"
Per chi sa farlo, bastano poche pagine per rendere indimenticabili personaggi e situazioni. In questo caso, ne bastano 137. La storia narra di Ezster e della sua vita piatta trascorsa in una (in)consapevole attesa dell'uomo che ha amato: Lajos, bugiardo della peggior specie, che mente "come urla il vento". Lajos un giorno torna e la narrazione prende avvio. Dal momento del suo ritorno, la vicenda si snoda tra gli eventi, senza mai smettere di pungolare il lettore, impotente e rassegnato, ché "gli amori infelici non finiscono mai". Un libro essenziale, privo di fronzoli, rapido, che scandaglia con precisione chirurgica le peggiori nefandezze dell'animo umano. Sandor Marai in quest'opera del 1939 anticipa quelle tematiche e quel particolare modo di costruire la narrazione - l'uso dei monologhi, la quasi totale assenza del narratore - che assurgeranno al massimo della loro completezza nella sua opera simbolo, le Braci, figlia del suo periodo più creativo. Se la nostra massima empatia accoglie a braccia aperta la figura di Ezster, che va subito a inserirsi nell'olimpo delle "sedotte e abbandonate" della letteratura, non possiamo altresì che rimanere estasiati - e pure contrariati - di fronte alla precisione psicologica nel rappresentare Lajos, personaggio tanto detestabile quanto vivido. Un romanzo da bere alla goccia, per godersi, sul finire, quel retrogusto di fiele che lascia sul palato e in fondo al cuore.
Recensione "La stiva e l'abisso" di Michele Mari
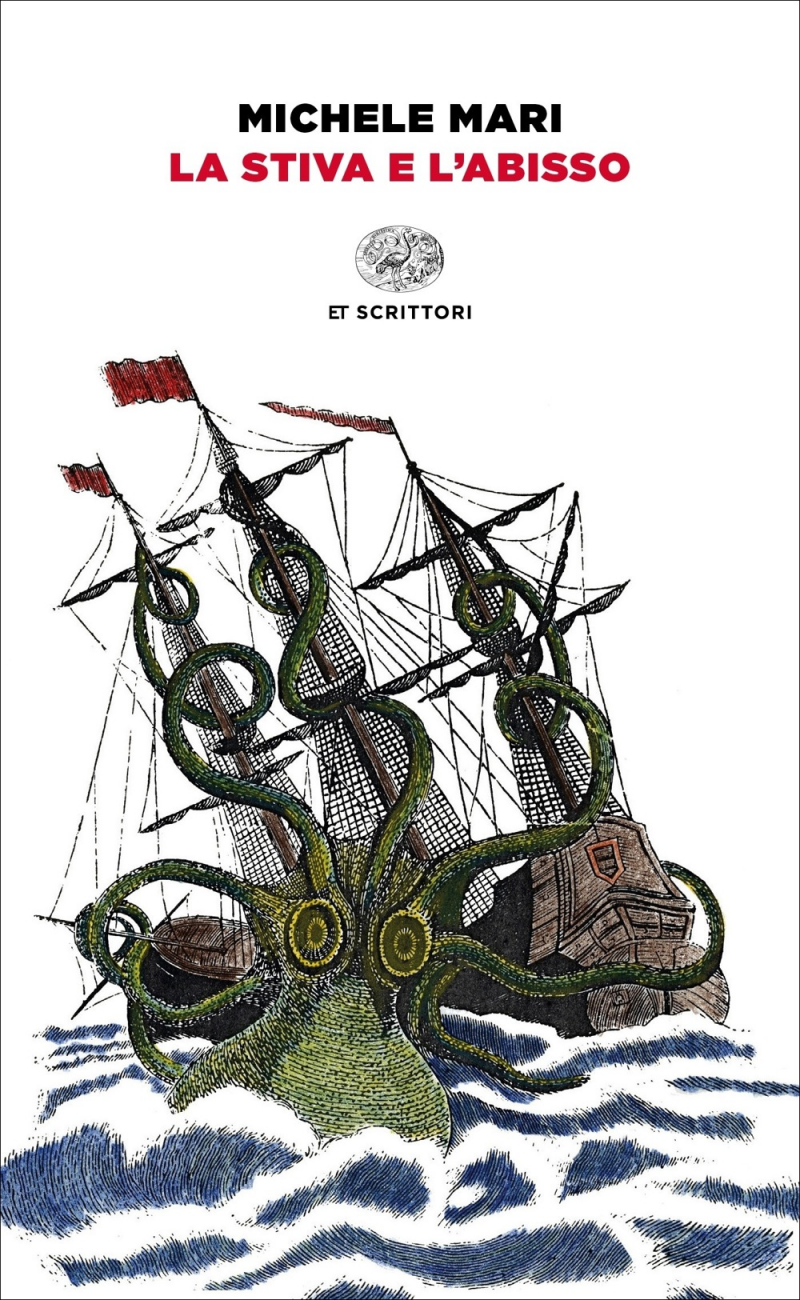
" ... È questo il bello dei racconti, hanno sempre qualcosa di oscuro"
Man mano che si ammassano gli anni, e soprattutto che si ammassano i libri, l'asticella del mio gusto letterario si alza sempre di più. È divenuto difficile stupirsi e rimanere basiti alla chiusura di un libro. Romanzi conclusi e inconcludenti, storie a metà , scritture scialbe e diafane... Sono tutte cose che ormai non fanno altro che infastidrmi. Io voglio che un libro sia un tuono: precipitato sulla mia terra con somma sorpresa e fautore, col propagarsi del suo boato, di una frattura in me. Questo del resto è lo scopo della letteratura: colpire il punto fragole e produrre pensiero . Se un libro non riesce in questo, se una storia non mi fa male e non mi stimola, allora non ne è valso tempo, e nemmeno soldi. Perché una volta concluso io sono lo stesso di sempre, ne so quanto prima, e i miei dubbi non sono aumentati. Il mio approccio alla lettura quindi è un inseguimento di stimoli, una caccia al titolo ché più possa darmi quel brivido e che più possa insinuare dubbi. Infatti, ho sempre pensato, la letteratura non dà risposte, o non sempre, e non è questo il suo compito precipuo, piuttosto, la letteratura genera dubbio. E io di dubbi sono sempre stato profondamente innamorato; ho bisogno, concluso il libro, di rimanere stordito, di lasciarmi sfuggire il senso, di non afferrare ciò che voleva dire l'autore, di arrivare a pensare, persino, che l'autore stesso non sapesse bene cosa comunicare. Leggere e non capire. Rileggere, pensare ancora e di più, fare congetture, riscrivere nella testa, ipotizzare, di nuovo leggere, perdersi nel dubbio. Questo è leggere. È nei punti oscuri, nel dubbio, che rinvengo alla scoperta di qualcos'altro, qualcosa che non so nominare prima di averla rinvenuta. Con la stiva e l'abisso è accaduto questo: una profonda incomprensione scaturita da un'esperienza di comunione profonda con la pagina. La trama è presto detta: un galeone è costretto da una misteriosa bonaccia a rimanere in mezzo all'oceano, immobile. Immobile come il suo capitano, inchiodato al letto, nella sua stiva, da una gangrena alla gamba. A dirla così, non pare nemmeno entusiasmante: la condizione di immobilità fa cadere seduta stante le aspettative di trovarsi di fronte a un racconto di avventure. Eppure delle avventure accadono, ma sono delirii, elucubrazioni, sono nella testa del capitano, che cerca di trovare una spiegazione alla misteriosa maglia di cui sembra essere preda il resto della ciurma, e sono nei discorsi dell'equipaggio, calati in una metamondo immaginario fatto di parole. E così, tra le bugie del secondo, Menzio, i dialoghi e le conversazioni estrapolate dai mozzi, si snocciola la narrazione, che una narrazione non è, o meglio, non è una sola: il ritmo diegetico infatti qui assume una sua peculiare essenza, ed è frammentato, misto, ha tante vite quante sono le voci dei membri dell'equipaggio, e a simboleggiare ciò, c'è la scelta del linguaggio da parte dell'autore, che tradisce un amore smisurato per l'abbondanza e il gusto barocco, e rivela plasticità e adattabilità impressionanti. I cambi di registro infatti la fanno da padrone, e ciò non è volto solo a differenziare lo status dei personaggi, ma anche a sottolineare l'approccio dei singoli rispetto all'ignoto, al mistero che serpeggia lungo i ponti della nave, al quale il capitano prova ad accedere nonostante le sue condizioni lo limitino. Alla stratificazione di registri corrisponde una stratificazione di significati, di tematiche, le quali si compenetrano, e ancora, di rimandi, di citazioni - con una certa inclinazione per il pastiche - di intenzioni, non mancando mai di fare sfoggio di erudizione, mai fuori posto. Sembrerebbe un caleidoscopio mal amalgamato di scelte stilistiche e tematiche, o un pastrocchio da vanaglorioso, ma il tutto, realizzato con grazia letteraria, converge verso un solo grande tema: quello della narrazione, che a sua volta metaforicamente simboleggia l'esistenza stessa. I marinai sul galeone, presi da questa malia - di cui si scoprirà essere responsabili dei magici pesci - raccontano storie e ascoltano i compagni narrarne altre; Torquemada, il capitano infermo, ascolta e partecipa alle narrazioni dalla stiva nella quale è immobilizzato, ha l'orecchio sempre teso, chiede resoconti dettagliati ai suoi sottoposti; Menzio, l'unico a non raccontare nulla, mente, mente per sua natura, come suggerisce il nome, e nel farlo, modifica il suo linguaggio, con toni parodistici, assorbendo come una spugna ciò che riesce raccogliere, affinando così di volta in volta la sua arte manipolatoria. A modo suo, anche lui fa una narrazione, non autentica, diremmo, e per questo non rimarrà impunito. È chiaro il contenuto del romanzo? No, assolutamente. È un groviglio di cose, un attorcigliamento di temi, di livelli di significato, di letture, di registri. La lingua, soprattutto, può risultare ostica; Ad esempio, in alcuni passaggi - soprattutto se sono i pensieri tortuosi di Torquemada - ci imbattiamo in termini desueti, arcaicismi, cerebralismi linguistici. Una vera goduria, per coloro che amano la lingua e apprezzano le volute manieristiche di chi sa usarla davvero, una tortura per quelli che si aspettano un racconto semplice, più consueto. La stiva e l'abisso è una lettura che crea dubbi, difficile per contenuto e per forma, difficile perché produce attrito e resistenza, da una parte, e dall'altra quella insana voglia di scavalcare i confini del detto per lanciarsi nel fiume dell'astrazione. Una cosa però è chiara: Mari è geniale, e il suo genio scaturisce da quel modo di narrare per il gusto di narrare, e mi viene da dire, collocandomi nel solco della metafora che parrebbe - e dico parrebbe - suggerire, vive per il gusto di vivere, come forse dovremmo fare tutti quanti, poiché, in fin dei conti, "vivere è attendere la morte".
I miei libri - Link per Acquistarli

Scene gonfie di malinconia, paesaggi agresti, tramonti a capofitto tra il grano, ricerca di identità, una Roma cupa e onirica, epitome di un patto d'amore dalle sembianze mitiche. E all'estremo opposto, una Pechino in bilico tra grattacieli asettici, corse in taxi e cascate di petali in una primavera improvvisa, sotto cieli di polline. E ancora lo sforzo di un amore mai corrisposto, una linea mozzata in balia di tensioni sempre opposte, la ricerca e la separazione, il volere e il non volere, il rimando al mito greco e latino, archetipi al servizio del racconto del dolore: questi i temi e le immagini ricorrenti nei componimenti di "Ho declinato tramonti", una sorta di diario intimo, che va a comporre pagine di ricordi e offre un quadro lirico, evocativo e immaginifico del bagaglio emotivo e delle esperienze della prima età adulta del giovane poeta romano.

“Aveva parlato di mosca cieca, il gioco che consiste nel bendare un malcapitato giocatore estratto a sorte e fuggire da lui." Essere privati della vista, lasciati a vagare nel nulla, preda di qualsiasi cosa si nasconda oltre la benda: questo è uno dei concetti alla base di Mosca Cieca, la prima prova narrativa di Matteo Zandri. Una raccolta di racconti che si spostano sulla stessa linea di fumo grigio. Essere diversi è una delle chiavi di lettura più incisive, in un universo dove personaggi e protagonisti nascondono sempre un doppiofondo inquietante. Diventa difficile scindere l’eroe dall’antagonista, il bianco dal nero, in un viaggio di trame in sospeso e nefandezze appena sussurrate.



Crea il tuo sito web con Webador